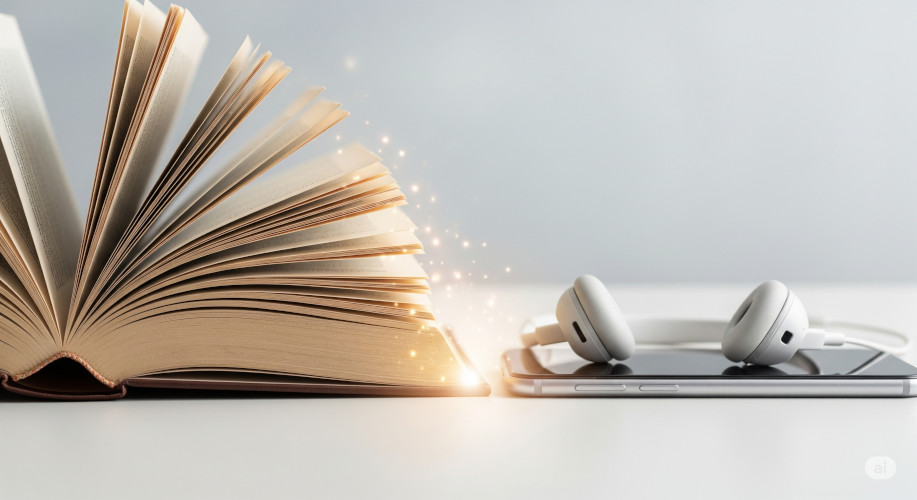Prima che esistessero libri, teatri o schermi, l’uomo raccontava. Attorno al fuoco, in capanne, corti o piazze, le parole viaggiavano da bocca a orecchio. La narrativa nasce così: come un’esigenza di tramandare, condividere e dare senso all’esperienza umana. Ogni comunità aveva i suoi narratori: figure centrali, carismatiche, capaci di evocare mondi attraverso la sola voce. Le storie erano vive, modellate dall’ascolto, mai uguali due volte.
La tradizione orale: un sapere vivo e collettivo
La tradizione orale era più di un passatempo: era educazione, memoria storica, rito. I miti fondativi, le leggende, le parabole morali: tutto veniva trasmesso oralmente. La parola era uno strumento di coesione sociale e identità. Ma soprattutto, era performativa: il narratore non leggeva, incarnava il racconto. Gestualità, ritmo, pause, intensità della voce: ogni elemento contribuiva a rendere la narrazione un’esperienza immersiva.
L’avvento della scrittura e la trasformazione della narrativa
Con la scrittura, le storie hanno trovato un nuovo supporto. La parola orale ha ceduto il passo alla parola scritta, e la narrativa è entrata in una fase più statica ma anche più duratura. Tuttavia, qualcosa si è perso: la dimensione collettiva e performativa. Il lettore è diventato solitario. Il racconto, da evento sociale, è divenuto intimo. Ma la memoria del racconto orale è rimasta impressa nell’evoluzione della letteratura stessa, che spesso ha cercato di ricrearne ritmo, tono e immediatezza.
Il ritorno della voce: podcast e nuova oralità
Negli ultimi anni assistiamo a un curioso ritorno: la voce torna protagonista. I podcast, e in particolare i podcast narrativi, hanno riportato l’arte del racconto in un formato orale. Ma con una differenza sostanziale: la tecnologia consente oggi di unire la forza dell’oralità con la cura della scrittura e della produzione sonora. Quello che ascoltiamo in cuffia è una nuova forma di cantastorie digitale, che può emozionarci mentre siamo in metropolitana o cuciniamo.
La narrativa nei podcast: tra intimità e universalità
Nei podcast narrativi, la voce si fa ponte tra autore e ascoltatore. L’intimità del mezzo – una voce che parla direttamente all’orecchio – restituisce alla narrazione quel carattere caldo, personale, quasi sacro, che aveva nelle società orali. Ogni episodio è come una serata attorno al fuoco, ma con una platea globale. È il trionfo della soggettività e allo stesso tempo della connessione umana: storie individuali che parlano a tutti.
Podcast e letteratura: un dialogo continuo
Molti podcast traggono ispirazione da testi letterari o ne sono diretta trasposizione. Questo dialogo tra oralità e scrittura è fertile e affascinante. Da un lato, la letteratura offre una profondità e una struttura narrativa solida. Dall’altro, il podcast restituisce voce e respiro alle parole. In questo senso, la narrativa nei podcast non è solo intrattenimento, ma anche un modo nuovo di “leggere” i libri, di renderli vivi, accessibili, emozionanti
Le storie sono ciò che ci definisce. Dalla tradizione orale ai podcast moderni, la narrativa ha cambiato forma ma non funzione. È rimasta un atto profondamente umano, un bisogno di connessione, significato, empatia. Oggi, ogni ascoltatore di podcast narrativi partecipa – magari inconsapevolmente – a una lunghissima catena: quella dei racconti che, da sempre, ci aiutano a essere umani.
Ascolta il nostro podcast di racconti
Se questo articolo ti ha incuriosito, forse dovresti ascoltare il nostro podcast: “Raccontiamoci“, con la voce di Giovanna Lauria.
Disponibile su Spotify, Apple Podcast, YouTube e tutte le principali piattaforme di streaming.